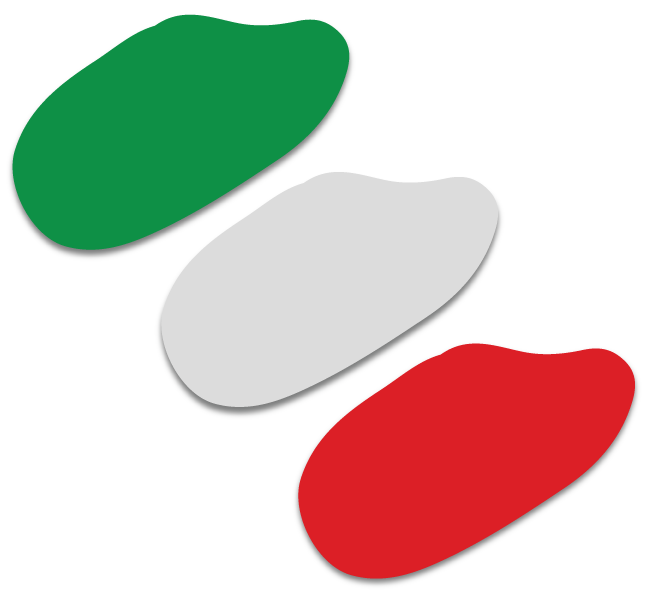Se otto ore ci sembran tante… è il titolo del convegno promosso a Vercelli dal Gruppo di Volpedo e dal circolo Modesto Cugnolio il 14 maggio in vista del 110° anniversario delle lotte sindacali in risicoltura che portarono – il 1 giugno del 1906 – al riconoscimento delle otto ore lavorative. Come si sa, le mondine furono le protagoniste di quelle lotte. Non tutti sanno invece che all’origine di quel movimento vi fu anche il lavoro di Modesto Cugnolio (foto piccola). L’argomento è stato sviscerato a Vercelli da Marco Barberis, già giornalista dell’Avanti!, e Giovanni Ferraris, presidente della società storica vercellese. Barberis ha spiegato che «celebrare oggi la conquista delle ” otto ore” di lavoro delle mondariso vercellesi- nel lontano 1906- con la devozione che si deve alla memoria di un passato di grandi sconfitte e di più grandi vittorie, vuol dire essere consapevoli che quelle lotte, quei dolorosi scontri sociali esprimono valori di tutta attualità e… parlano ancora al cuore e alla mente della nostra gente. Nel 1976, giovane assessore alla cultura della giunta comunale di Vercelli, retta da Ennio Baiardi, organizzai al Teatro Civico la manifestazione celebrativa per la ricorrenza settantennale quando ancora alcune testimoni ultra ottuagenarie erano in vita e narrarono episodi di quelle giornate infuocate. L’evento trovò il suggello in una pubblicazione curata dalla civica amministrazione che riporta la cronaca degli avvenimenti e raccoglie gli atti del processo seguito agli scontri di piazza: 26 persone tradotte in catene di cui 11 donne: la più giovane con 16 anni, la più anziana di 32. E nella prefazione che il leader socialista Pietro Nenni scrisse di suo pugno: «le mondine assolsero ad un mandato in certo qual senso prioritario, quello di aprire la via alle più vaste agitazioni contadine e bracciantili, mentre nasceva la grande industria sulla quale doveva poi trasferirsi l’onere più pesante della lotta di classe…».
Se otto ore ci sembran tante… è il titolo del convegno promosso a Vercelli dal Gruppo di Volpedo e dal circolo Modesto Cugnolio il 14 maggio in vista del 110° anniversario delle lotte sindacali in risicoltura che portarono – il 1 giugno del 1906 – al riconoscimento delle otto ore lavorative. Come si sa, le mondine furono le protagoniste di quelle lotte. Non tutti sanno invece che all’origine di quel movimento vi fu anche il lavoro di Modesto Cugnolio (foto piccola). L’argomento è stato sviscerato a Vercelli da Marco Barberis, già giornalista dell’Avanti!, e Giovanni Ferraris, presidente della società storica vercellese. Barberis ha spiegato che «celebrare oggi la conquista delle ” otto ore” di lavoro delle mondariso vercellesi- nel lontano 1906- con la devozione che si deve alla memoria di un passato di grandi sconfitte e di più grandi vittorie, vuol dire essere consapevoli che quelle lotte, quei dolorosi scontri sociali esprimono valori di tutta attualità e… parlano ancora al cuore e alla mente della nostra gente. Nel 1976, giovane assessore alla cultura della giunta comunale di Vercelli, retta da Ennio Baiardi, organizzai al Teatro Civico la manifestazione celebrativa per la ricorrenza settantennale quando ancora alcune testimoni ultra ottuagenarie erano in vita e narrarono episodi di quelle giornate infuocate. L’evento trovò il suggello in una pubblicazione curata dalla civica amministrazione che riporta la cronaca degli avvenimenti e raccoglie gli atti del processo seguito agli scontri di piazza: 26 persone tradotte in catene di cui 11 donne: la più giovane con 16 anni, la più anziana di 32. E nella prefazione che il leader socialista Pietro Nenni scrisse di suo pugno: «le mondine assolsero ad un mandato in certo qual senso prioritario, quello di aprire la via alle più vaste agitazioni contadine e bracciantili, mentre nasceva la grande industria sulla quale doveva poi trasferirsi l’onere più pesante della lotta di classe…».Le 8 ore erano diventate una realtà unitamente alla paga oraria di 25 centesimi». Come ha ricordato Barberis, la legge che regolamenterà l’orario di lavoro dovrà attendere ancora alcuni anni, fino al 1911. Il dado, tuttavia, era tratto e a propiziare la svolta erano stati personaggi come il Cugnolio. Questo è il ritratto che ne fa il professor Ferraris: «Modesto Cugnolio nacque a Vercelli da Pietro e da Giuseppina Riva il 21-3-1863. Di famiglia agiata, fu educato dai Barnabiti di Moncalieri, cioè nel più aristocratico collegio del Piemonte. Si laureò in legge nell’Università di Torino. Avendo incominciato a esercitare la professione forense, venne subito a contatto con la più triste realtà del Paese. Già nel 1897, nelle sue prime cause penali, si trovò a dover difendere politici perseguitati e umili lavoratori, e 1a sua partecipazione al ruolo di difensore fu cosi intensa e vissuta che durante le agitazioni del 1898 le autorità lo cacciarono in prigione per tre settimane. Nella torre del castello del Beato Amedeo, a Vercelli, fece la scelta della sua vita: entrato borghese, uscì socialista. Cugnolio ricoprì varie cariche pubbliche: consigliere comunale a Vercelli dal 1909; eletto alla Camera nel 1913; consigliere provinciale per il collegio di San Germano Vercellese dal 1914. Fu membro dell’Amministrazione dell’Ospedale Maggiore di Vercelli e consigliere della Stazione Sperimentale di Risicoltura. Morì di polmonite e Roma il 18 marzo 1917. Una settimana prima aveva parlato alla Camera sulle condizioni dell’agricoltura durante la guerra. Fu un discorso molto contestato da rumori e da intemperanze. Cugnolio appariva indisposto e affaticato, ma tenne testa agli oppositori sino alla fine, compiendo una fatica superiore alle sue forze. Subito dopo si rifugiò in albergo, dove si pose a letto per non rialzarsi più.Per i contadini della pianura vercellese egli è stato voce, guida, apostolo. Il miglioramento della condizione umana del lavoro in risaia è stato lo scopo essenziale della sua esistenza. Nel suo testamento egli chiese: “solo funerali civili e i miei contadini”. E dalle campagne “i suoi” contadini accorsero a migliaia al suo funerale, assiepandosi nelle strade di Vercelli come mai era avvenuto. E’ sepolto a Vercelli nel cimitero di Biliemme; per lascito testamentario la tomba deve essere mantenuta in buone condizioni dall’Ospedale S. Andrea, cioè dall’ASL di Vercelli. Cugnolio svolse un’intensa attività sindacale e politica. Nel Vercellese organizzò le prime leghe contadine, organizzò il partito, guidò agitazioni e scioperi che, vittoriosi o meno, a poco a poco resero meno disumane le condizioni di vita dei lavoratori delle risaie. Con i contadini a poco a poco riuscì a stabilire un efficace contatto umano. Nei comizi che faceva nei paesi parlava in dialetto, esponendo le sue idee con semplicità. Nel 1901 fondò La Risaia di cui fu direttore politico. Ne1 1903, per dissensi con i suoi compagni, lasciò La Risaia e fondò La Monda, che ebbe vita breve; infatti, le esigenze unitarie dell’azione sindacale e politica sanarono presto il piccolo scisma e Cugnolio ritornò alla guida delle organizzazioni proletarie locali. Ebbe un’enorme risonanza la lunga lotta che ingaggiò per limitare a otto ore il lavoro in risaia. Fu una lotta contro una mentalità, contro presunte ragioni di tecnica agricola, contro non piccoli interessi economici e persino contro autorevolissimi compagni di partito. Incominciò avanzando motivazioni giuridiche. Andò a riesumare un vecchio regolamento fatto per debellare la malaria (il regolamento Cantelli), che era rimasto sempre inosservato ed obliato per oltre un trentennio, ma che in pratica non consentiva più di otto ore di lavoro in risaia, e ne sollecitò I’applicazione, creando sconcerti ed imbarazzi. In questo modo i legalitari di sempre, gli agrari, vennero a trovarsi nell’illegalità, mentre i contadini divennero i fautori del rispetto della legge.
L’opera di Cugnolio per tutto il biennio 1904-1905 fu di instancabile, paziente e martellante tenacia nello spingere all’azione carabinieri, sotto-prefetti e magistrati al fine di far rispettare il regolamento Cantelli. Con tale azione conseguì il duplice risultato d’incrinare il fronte padronale e di creare attorno al concetto delle otto ore la solidarietà delle leghe, che ora si davano un grande obiettivo di lotta. Gli agrari, con la complicità del governo, riuscirono a fare abolire il regolamento Cantelli, ma non riuscirono più ad arrestare la poderosa spinta di migliaia di lavoratori, decisi ormai ad ottenere come conquista sindacale ciò che non veniva più concesso in forza di legge.
Nel 1906, I’anno dei grandi scioperi, Cugnolio superò se stesso dimostrando capacità politiche e sindacali eccezionali, ma soprattutto dimostrando doti di straordinaria umanità, che gli diedero la possibilità di portare i contadini alla vittoria senza quei tragici eccessi, che altrove, per vertenze sindacali di minor conto, insanguinarono le campagne. Con questo suo metodo coscienzioso e antidemagogico, non solo riuscì a fare progressivamente accettare il limite delle otto ore, ma, sebbene non fosse ancora deputato, riuscì a fare migliorare tutta la legislazione che regolava il lavoro in risaia. La bontà dell’opera di redenzione promossa da Cugnolio cosi fu descritta dall’on. Savio: “Ove prima non si vedevano che persone gialle, scarnate e sonnacchiose, oggi esultano il vigore fisico e I’agilità mentale. Gli stambugi di abitazione si sono tramutati in linde camerette”. Sono poche parole che valgono più di un monumento. Degno di particolare attenzione è il rapporto fra Cugnolio e il suo partito, che nel Vercellese egli fece sorgere quasi dal nu1la. I motivi di dissenso furono molti. Sovente i massimi dirigenti del PSI dovettero accorrere a Vercelli per sanare i contrasti che sorgevano fra le leghe e la Camera del Lavoro da una parte (dove Cugnolio esercitava maggiormente il suo ascendente) e la Federazione e 1e Sezioni del Partito (specialmente quella di Vercelli) dall’altra.
Scrisse di lui Felice Angelo Fietti, suo compagno di lotta politica: “Il suo cervello era troppo analitico, il suo carattere troppo indipendente. Donde i dissidi con i suoi compagni, dissidi però sorti sempre e unicamente sulla valutazione dei metodi di lotta, mai sulla bellezza e bontà intrinseca dell’idea. Perché Modesto Cugnolio venne a noi attratto dal fascino che sprigiona il nostro ideale di fratellanza umana… “.
Cugnolio non era uomo da lasciarsi facilmente incastrare negli schematismi di partito. La sua formazione spirituale era classica, i suoi interessi culturali erano intensi e molteplici, la sua mente era portata all’indagine critica. Conseguentemente anche le sue scelte politiche, sindacali e amministrative non furono mai conformiste e talvolta risultarono molto scomode ed ingombranti per il partito, in cui egli rimaneva un solitario. L’ideale di libertà, insieme con il profondo convincimento che questo ideale non poteva in concreto svilupparsi se non in un mondo di eguali, fu l’ideale semplice e supremo di Modesto Cugnolio. Scrisse di lui l’on. Fabrizio Maffi, suo compagno e molte volte suo avversario interno di partito: “egli non ebbe mai feticci e non li creò mai: fu sempre un uomo libero nella parola e nella vita”. La composizione senza gravi incidenti della vertenza del 1906, con la conquista delle otto ore giornaliere nei lavori di risaia, sollevò vari interrogativi su come, il pur abile Cugnolio, fosse riuscito a “convincere” gli agrari. Una forte tradizione orale volle che le trattative più proficue si fossero svolte “tra squadra e compasso”, come si dice in gergo. D’altronde, ricerche d’archivio hanno permesso di stabilire, senza ombra di dubbio, che Cugnolio fu affiliato alla Massoneria. D’altronde, durante e dopo il Congresso di Ancona, dove, su proposta di Mussolini, fu dichiarata l’incompatibilità fra f iscrizione al PSI e l’appartenenza alla Massoneria, Cugnolio continuò a difendere la posizione contraria, nonostante i fulmini del Partito.
Cugnolio non era il solo massone militante nel PSI vercellese dell’epoca. La doppia appartenenza accumunava anche i seguenti socialisti vercellesi: Lorenzo Somaglino (1870 – 1929), tipografo, pioniere del socialismo vercellese, fu erede politico di Cugnolio e sindaco di Vercelli (1920-1922). Il maestro Felice Angelo Fietti (1871-1939), di Pezzana, confinato a Lampedusa, Ustica e Ponza dal 1927 al 1929. Su La Risaia Fietti scrisse il 18 aprile 1914: “La Massoneria permette ai suoi adepti la più completa libertà come prova il fatto che vi appartennero, per quanto è noto, persone delle più diverse opinioni politiche ed economiche, come Carlo Marx, Andrea Costa, Garibaldi e altri”. Il pavese Fabrizio Maffi (1868 – 1955), medico a Bianzé e membro del Circolo Socialista Vercellese, antifascista, fu membro del Comitato Centrale del PCI. Alessandro Gionino (1879-1942), maestro di San Germano Vercellese, socialista militante e collaboratore de La Risaia. Gli agricoltori vercellesi ancora oggi non hanno “digerito” Cugnolio; nel primo dopoguerra fu poi una contrapposizione continua tra amministrazioni di sinistra che gli intitolavano una via e successive amministrazioni di parte opposta la cancellavano. Qualche intitolazione ancora resiste, in particolare resiste a Vercelli Piazza Cugnolio».