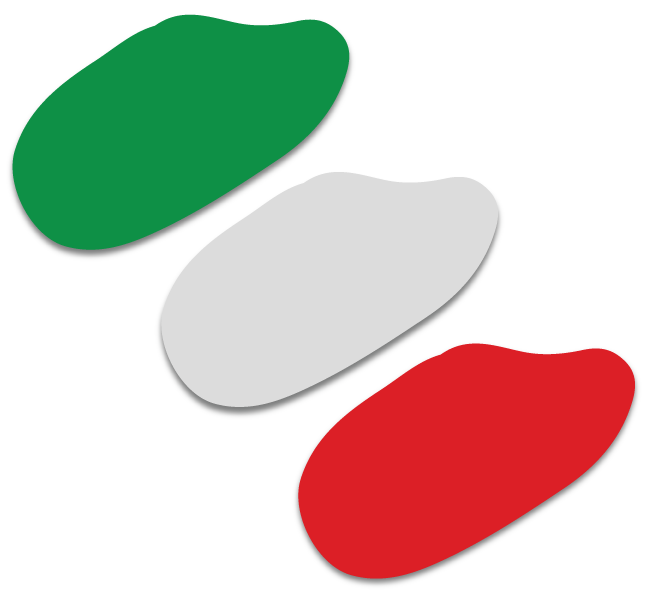«Dalla lavorazione fino alla cottura: una «pianta di civiltà», metafora dell’individuo che si apre alla società». Enzo Bianchi, il priore di Bose, ci regala quest’immagine del riso sulla Stampa del 10 agosto. Il suo articolo è un ricordo intenso: «Da quando vivo a Bose – scrive – le risaie hanno sostituito la vigna nell’indicarmi l’alternarsi delle stagioni: dalla grande finestra della mia cella sul versante orientale della Serra d’Ivrea lo sguardo va verso Vercelli e Novara e i loro campanili nel chiarore della sera, con la luminosità che sale nell’oscurità della notte, ma al mattino vedo la pianura che li circonda ricoprirsi d’acqua mentre la nebbia si dissolve e il sole che sorge vi si riflette come in un lago: è la primavera che si affaccia. Poi un verde brillante disposto a scacchiera segna l’estate: lo attraverso ogni volta che mi sposto in auto per il mio lavoro o anche per raggiungere qualche amico al di là del Po e per tornare nel mio Monferrato. Sovente un airone cinerino mi guarda incuriosito dal suo regno di terra, di acqua e di verde, mentre un altro, forse più giovane, si alza in volo, chissà se impaurito oppure soltanto desideroso di godersi dall’alto quello spettacolo di colori e di tonalità diverse di verde. In autunno, a prevalere è il giallo scuro ambrato che altre pianure conoscono con il grano a giugno: segnale dell’imminente mietitura, mi ricorda come ogni creatura si riveste di splendore mentre si piega carica del frutto che porta. Infine i segnali di fumo delle stoppie bruciate in giornate nebbiose mi annunciano l’inverno: tra poco dal bianco della neve emergeranno i monconi carbonizzati delle piante di riso troncate. Le risaie, prima di essere la culla dell’alimento principale di oltre la metà della popolazione mondiale, sono una delle dimostrazioni più eloquenti del rapporto tra coltura e cultura: fare spazio a un cereale proveniente dall’estremo oriente, modellare la pianura anno dopo anno, progettare una rete di canali e di fossi e ripartire il terreno in «camere», come se i campi fossero il disegno a cielo aperto della pianta di una casa in costruzione, con le paratie e le chiuse al posto degli usci… Tutto questo richiede l’assunzione di un preciso modo di pensare e di porsi in rapporto alla terra, all’acqua e agli altri, non fosse che per coordinare il momento cruciale in cui il terreno seminato viene ricoperto da un velo e diviene terra d’acqua. Ma il riso è «pianta di civiltà» anche e soprattutto per la tipologia di lavoro che richiede: oggi la meccanizzazione ha cambiato molte cose, ma non è ancora scomparsa la generazione delle «mondine», di cui l’indimenticabile, insuperabile signora, Silvana Mangano di Riso amaro è divenuta icona. Donne sottoposte a fatiche incredibili, curvate sotto il sole, con i piedi per ore nell’acqua tiepida, avvolte da nugoli di zanzare, eppure capaci di cantare le loro speranze e la loro rabbia, di danzare sull’aia al termine del lavoro, di organizzarsi nelle prime leghe di lavoratrici contro lo sfruttamento… Il loro compito originario – mondare il riso, cioè liberarlo dalle erbacce, operazione assolutamente necessaria anche se in contrasto con la parabola evangelica del grano e della zizzania da lasciar crescere insieme fino alla mietitura… – si estende in seguito all’ancor più estenuante fatica del trapianto, ma non spegne la loro gioia di vivere o, meglio, la loro ferrea volontà di guadagnare da vivere per sé e per i propri cari, sovente lontani e in attesa del ricongiungimento a fine stagione. C’era fame allora, e questo imponeva di cercare pane anche lontano da casa e di affrontare fatiche oggi insopportabili o impensabili. Nel frattempo, le poche ore sottratte al riposo per alzare lo sguardo a orizzonti più ampi della pianura vengono spese per trovare consolazione in parrocchia davanti a un Crocifisso o per cercare giustizia e rispetto nella solidarietà degli ultimi. Chi, come me, ha ancora avuto la possibilità di conoscere qualcuna di queste donne e accoglierne i racconti, non può dimenticarne la voce rimasta squillante nonostante lo scorrere degli anni, lo sguardo che – abituato a guardare il suolo e discernere sul nascere cioè che dà frutto e ciò che invece sfrutta il terreno – si alza fiero e si fissa sugli occhi dell’interlocutore, lo stare salde di fronte alle prove e, al contempo, la capacità di curvarsi verso chi è più provato di loro… È cultura del riso anche la convivenza forzata degli uomini nelle cascine durante i giorni del raccolto: con un semplice giaciglio nel fienile, con l’attesa di un salario che spesso non è altro che qualche sacco di riso, con il ritrovarsi la domenica all’osteria, davanti a una bottiglia di vino che, per quanto piena, non riesce mai a colmare il vuoto del cuore, ma solo ad appesantire la testa e i ricordi… Ricordo come nel dopoguerra i carri venivano in Monferrato dal vercellese, scambiando i loro sacchi di riso con il nostro vino in damigiane: erano tempi duri, eppure quei contadini poveri hanno saputo forgiare molti ideali per un cammino di umanizzazione: la giustizia, la solidarietà, la comune condizione che ci impegna nel duro mestiere di vivere e guadagnarsi il pane. Il riso poi dava lezioni di vita anche a noi bambini: ci veniva chiesto di vagliare i chicchi crudi in un piatto per togliere pietruzze o altre impurità. Noi vivevamo quell’incarico come un gioco, ma in realtà imparavamo a riconoscere e apprezzare ciò che avremmo mangiato. Varrebbe la pena che oggi i ragazzi venissero accostati a un mondo che non è del tutto scomparso: una visita alla cascina Colombara di Livorno Ferraris, dove si produce lo squisito riso Acquerello, farebbe scoprire loro com’era una cascina con le sue stalle, le stanze per i macchinari, tutte costruzioni basse e allineate, me moria viva della povertà di un tempo ma anche della cultura del lavoro, dell’onesta fatica per procurarsi da mangiare, della convergenza di persone e mezzi per ottenere il miglior risultato possibile. Ma la «civiltà» del riso si sprigiona in tutta la sua forza ancora oggi a tavola. Certo, quando ripercorro le risaie non trovo più l’osteria di Salasco, dove gli avventori man mano che sopraggiungevano si sedevano l’uno accanto all’altro in un’unica tavolata, aspettando davanti alla tela cerata che la padrona-cuoca-cameriera servisse la «panissa», mirabile connubio di riso, fagioli, salsiccia e vino. Ma qualcosa di quel rito campestre rimane ogni volta che preparo un risotto per dire «ti voglio bene» alle persone che mi sono care. Subito dopo la tostatura dei chicchi in pochissimo olio, faccio sfumare un bicchiere di vermouth Martini bianco e aggiungo la salamella e i fagioli, già cotti ma ancora un po’ al dente. Poi con il magico, immancabile cucchiaio di legno rimescolo il tutto, accarezzando il riso e aggiungendo il brodo. Il fuoco deve farlo sobbollire in modo uniforme, mai violento, mai eccessivo: costante regolazione della fiamma e sapiente rimescolamento distribuiscono il calore in modo equo per tutto il tegame. Quando il riso è quasi cotto, spengo il fuoco, lascio riposare due minuti e aggiungo una manciata di parmigiano grattugiato: il risotto deve restare «all’onda», deve cioè avere quella consistenza che lo fa adagiare sul piatto di portata come l’acqua del mare sul bagnasciuga, senza debordare. Così la panissa è pronta, piatto unico che rallegra il cuore e rinsalda l’amicizia tra chi la gusta. A questa tavola della semplicità, mi ritrovo in quanto scriveva Pasolini, con il suo acume contadino: “Allora vivevano l’età del pane, erano cioè consumatori di beni estremamente necessari ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita”». (11.08.14)
«Dalla lavorazione fino alla cottura: una «pianta di civiltà», metafora dell’individuo che si apre alla società». Enzo Bianchi, il priore di Bose, ci regala quest’immagine del riso sulla Stampa del 10 agosto. Il suo articolo è un ricordo intenso: «Da quando vivo a Bose – scrive – le risaie hanno sostituito la vigna nell’indicarmi l’alternarsi delle stagioni: dalla grande finestra della mia cella sul versante orientale della Serra d’Ivrea lo sguardo va verso Vercelli e Novara e i loro campanili nel chiarore della sera, con la luminosità che sale nell’oscurità della notte, ma al mattino vedo la pianura che li circonda ricoprirsi d’acqua mentre la nebbia si dissolve e il sole che sorge vi si riflette come in un lago: è la primavera che si affaccia. Poi un verde brillante disposto a scacchiera segna l’estate: lo attraverso ogni volta che mi sposto in auto per il mio lavoro o anche per raggiungere qualche amico al di là del Po e per tornare nel mio Monferrato. Sovente un airone cinerino mi guarda incuriosito dal suo regno di terra, di acqua e di verde, mentre un altro, forse più giovane, si alza in volo, chissà se impaurito oppure soltanto desideroso di godersi dall’alto quello spettacolo di colori e di tonalità diverse di verde. In autunno, a prevalere è il giallo scuro ambrato che altre pianure conoscono con il grano a giugno: segnale dell’imminente mietitura, mi ricorda come ogni creatura si riveste di splendore mentre si piega carica del frutto che porta. Infine i segnali di fumo delle stoppie bruciate in giornate nebbiose mi annunciano l’inverno: tra poco dal bianco della neve emergeranno i monconi carbonizzati delle piante di riso troncate. Le risaie, prima di essere la culla dell’alimento principale di oltre la metà della popolazione mondiale, sono una delle dimostrazioni più eloquenti del rapporto tra coltura e cultura: fare spazio a un cereale proveniente dall’estremo oriente, modellare la pianura anno dopo anno, progettare una rete di canali e di fossi e ripartire il terreno in «camere», come se i campi fossero il disegno a cielo aperto della pianta di una casa in costruzione, con le paratie e le chiuse al posto degli usci… Tutto questo richiede l’assunzione di un preciso modo di pensare e di porsi in rapporto alla terra, all’acqua e agli altri, non fosse che per coordinare il momento cruciale in cui il terreno seminato viene ricoperto da un velo e diviene terra d’acqua. Ma il riso è «pianta di civiltà» anche e soprattutto per la tipologia di lavoro che richiede: oggi la meccanizzazione ha cambiato molte cose, ma non è ancora scomparsa la generazione delle «mondine», di cui l’indimenticabile, insuperabile signora, Silvana Mangano di Riso amaro è divenuta icona. Donne sottoposte a fatiche incredibili, curvate sotto il sole, con i piedi per ore nell’acqua tiepida, avvolte da nugoli di zanzare, eppure capaci di cantare le loro speranze e la loro rabbia, di danzare sull’aia al termine del lavoro, di organizzarsi nelle prime leghe di lavoratrici contro lo sfruttamento… Il loro compito originario – mondare il riso, cioè liberarlo dalle erbacce, operazione assolutamente necessaria anche se in contrasto con la parabola evangelica del grano e della zizzania da lasciar crescere insieme fino alla mietitura… – si estende in seguito all’ancor più estenuante fatica del trapianto, ma non spegne la loro gioia di vivere o, meglio, la loro ferrea volontà di guadagnare da vivere per sé e per i propri cari, sovente lontani e in attesa del ricongiungimento a fine stagione. C’era fame allora, e questo imponeva di cercare pane anche lontano da casa e di affrontare fatiche oggi insopportabili o impensabili. Nel frattempo, le poche ore sottratte al riposo per alzare lo sguardo a orizzonti più ampi della pianura vengono spese per trovare consolazione in parrocchia davanti a un Crocifisso o per cercare giustizia e rispetto nella solidarietà degli ultimi. Chi, come me, ha ancora avuto la possibilità di conoscere qualcuna di queste donne e accoglierne i racconti, non può dimenticarne la voce rimasta squillante nonostante lo scorrere degli anni, lo sguardo che – abituato a guardare il suolo e discernere sul nascere cioè che dà frutto e ciò che invece sfrutta il terreno – si alza fiero e si fissa sugli occhi dell’interlocutore, lo stare salde di fronte alle prove e, al contempo, la capacità di curvarsi verso chi è più provato di loro… È cultura del riso anche la convivenza forzata degli uomini nelle cascine durante i giorni del raccolto: con un semplice giaciglio nel fienile, con l’attesa di un salario che spesso non è altro che qualche sacco di riso, con il ritrovarsi la domenica all’osteria, davanti a una bottiglia di vino che, per quanto piena, non riesce mai a colmare il vuoto del cuore, ma solo ad appesantire la testa e i ricordi… Ricordo come nel dopoguerra i carri venivano in Monferrato dal vercellese, scambiando i loro sacchi di riso con il nostro vino in damigiane: erano tempi duri, eppure quei contadini poveri hanno saputo forgiare molti ideali per un cammino di umanizzazione: la giustizia, la solidarietà, la comune condizione che ci impegna nel duro mestiere di vivere e guadagnarsi il pane. Il riso poi dava lezioni di vita anche a noi bambini: ci veniva chiesto di vagliare i chicchi crudi in un piatto per togliere pietruzze o altre impurità. Noi vivevamo quell’incarico come un gioco, ma in realtà imparavamo a riconoscere e apprezzare ciò che avremmo mangiato. Varrebbe la pena che oggi i ragazzi venissero accostati a un mondo che non è del tutto scomparso: una visita alla cascina Colombara di Livorno Ferraris, dove si produce lo squisito riso Acquerello, farebbe scoprire loro com’era una cascina con le sue stalle, le stanze per i macchinari, tutte costruzioni basse e allineate, me moria viva della povertà di un tempo ma anche della cultura del lavoro, dell’onesta fatica per procurarsi da mangiare, della convergenza di persone e mezzi per ottenere il miglior risultato possibile. Ma la «civiltà» del riso si sprigiona in tutta la sua forza ancora oggi a tavola. Certo, quando ripercorro le risaie non trovo più l’osteria di Salasco, dove gli avventori man mano che sopraggiungevano si sedevano l’uno accanto all’altro in un’unica tavolata, aspettando davanti alla tela cerata che la padrona-cuoca-cameriera servisse la «panissa», mirabile connubio di riso, fagioli, salsiccia e vino. Ma qualcosa di quel rito campestre rimane ogni volta che preparo un risotto per dire «ti voglio bene» alle persone che mi sono care. Subito dopo la tostatura dei chicchi in pochissimo olio, faccio sfumare un bicchiere di vermouth Martini bianco e aggiungo la salamella e i fagioli, già cotti ma ancora un po’ al dente. Poi con il magico, immancabile cucchiaio di legno rimescolo il tutto, accarezzando il riso e aggiungendo il brodo. Il fuoco deve farlo sobbollire in modo uniforme, mai violento, mai eccessivo: costante regolazione della fiamma e sapiente rimescolamento distribuiscono il calore in modo equo per tutto il tegame. Quando il riso è quasi cotto, spengo il fuoco, lascio riposare due minuti e aggiungo una manciata di parmigiano grattugiato: il risotto deve restare «all’onda», deve cioè avere quella consistenza che lo fa adagiare sul piatto di portata come l’acqua del mare sul bagnasciuga, senza debordare. Così la panissa è pronta, piatto unico che rallegra il cuore e rinsalda l’amicizia tra chi la gusta. A questa tavola della semplicità, mi ritrovo in quanto scriveva Pasolini, con il suo acume contadino: “Allora vivevano l’età del pane, erano cioè consumatori di beni estremamente necessari ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita”». (11.08.14)
«LA LOMBARDIA NON DICHIARA GUERRA AGLI ERBICIDI»
Ci risponde il direttore della DG agricoltura della Regione Lombardia